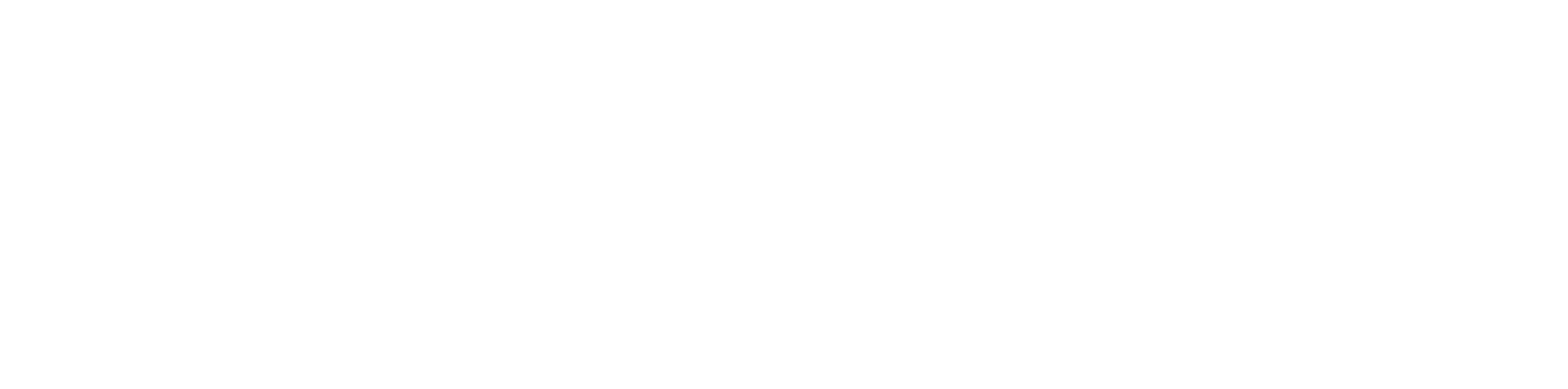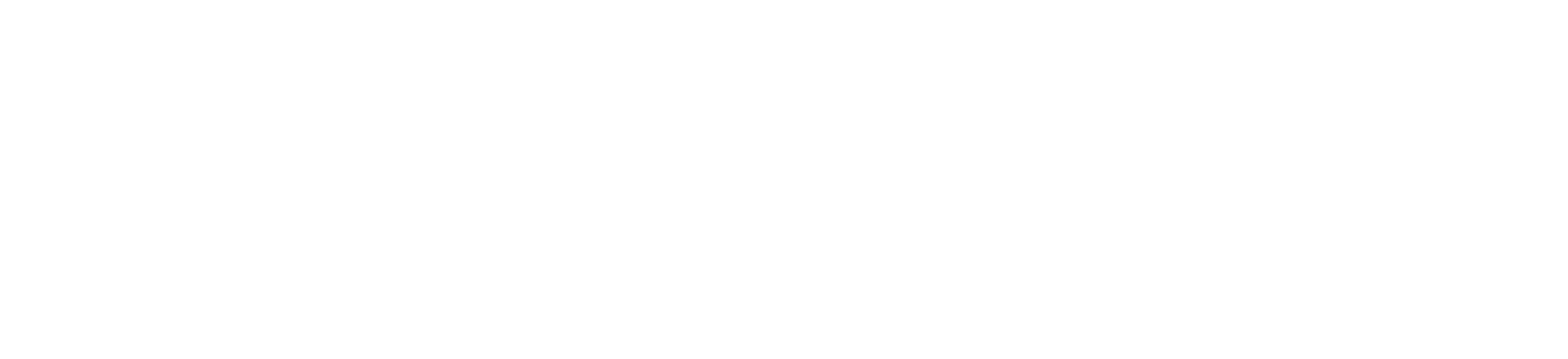Secondo quanto ha dichiarato il Ministero delle Infrastrutture nel 2022, i trasporti generano un quarto delle emissioni di gas serra nazionali e più del 92% è attribuibile al trasporto su gomma, per passeggeri o merci; il settore assorbe il 68% della domanda nazionale di prodotti petroliferi, la cui produzione dipende per oltre il 95% da importazioni di greggio dall’estero.
Il rapporto 2023 di Legambiente “Mal’Aria di città. Cambio di passo cercasi” denuncia una decrescita troppo lenta dell’inquinamento atmosferico delle città italiane, con livelli ancora troppo lontani dagli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (europei e globali) e dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sui limiti delle concentrazioni da non superare per tutelare la salute delle persone. Cosa si sta facendo per migliorare la situazione?
L’Europa, con il Green Deal, bibbia della transizione ecologica, stabilisce l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 al 2050, con un significativo risultato intermedio del -55% nel 2030: nelle strategie indicate per accelerare la transizione energetica ed ecologica, il trasporto è inevitabilmente un’area di prioritaria attenzione con un preciso action plan, il ‘Sustainable and smart mobility strategy’.
Da un punto di vista economico, per centrare congiuntamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, di tutela del valore dell’industria automotive e di ottimizzazione del sistema trasporti, si sta sostenendo la transizione verso un modello di mobilità che passa da soluzioni di progressiva ibridizzazione, sino alla completa elettrificazione, o comunque totale indipendenza da motori che non siano a emissione zero. Ma non solo. La costruzione della mobilità del futuro passa attraverso normative nazionali e politiche urbane, a sostegno di una mobilità pubblica più efficiente, accessibile e inclusiva; e di quella condivisa, capace di ridurre l’impatto sull’ambiente e sul traffico (oltre che sulle tasche dei cittadini).
Per le città, le variabili su cui intervenire includono l’ampliamento del parco mezzi e delle linee di servizio, il potenziamento dei collegamenti ai nodi intermodali da e verso le aree periurbane ed extraurbane. Inoltre, tutti i veicoli del trasporto pubblico su strada devono essere elettrificati. La digitalizzazione e l’analisi delle informazioni sulla mobilità sono la chiave per attivare, tra le altre cose, lo sviluppo di soluzioni Mobility as a Service (Maas), ovvero servizi digitali che promuovono la mobilità collettiva e condivisa, consentendo agli utenti di pianificare, prenotare e pagare più tipi di servizi di mobilità da un’unica applicazione.
Gli investimenti in ricerca e sviluppo per tecnologie, carburanti a minor impatto ambientale e diffusione di una cultura della mobilità green, sicura e resiliente, sono al centro delle attività del ‘Centro Nazionale per la mobilità sostenibile’ nato lo scorso anno su iniziativa del Politecnico di Milano (in linea e con risorse PNRR), che riunisce in un centro di eccellenza oltre 49 partner tra pubblico e privato, 24 le sole università.
Come si spostano gli italiani
L’Osservatorio sulle tendenze di mobilità della Struttura Tecnica di Missione (STM) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) pubblica regolarmente un’analisi dettagliata delle tendenze di mobilità al fine di monitorare l’evoluzione e le esigenze del settore dei trasporti e della logistica. I dati 2022 restituiscono uno scenario di graduale recupero delle tendenze pre-pandemia, senza evidenziare forti cambi di rotta verso una combinazione modale di sostanziale evoluzione, come le prescrizioni per l’avvento di una mobilità sostenibile auspicherebbero.
Il trasporto stradale passeggeri, sta pian piano recuperando i livelli 2019, mentre il trasporto merci di veicoli pesanti segna performance di crescita. Il trasporto ferroviario resta ancora fortemente penalizzato, come anche quello pubblico locale. Resta ancora inferiore al 2019 la domanda dei passeggieri per il trasporto aereo; ma un timido segnale positivo lo registra invece il trasporto merci, a conferma del ritorno di una certa dinamicità del commercio internazionale. Il traporto marittimo, i traghetti per passeggeri, è l’unico a registrare un dato di significativa crescita.
La maggior parte degli italiani, sia per brevi che per lunghe distanze, tende dunque ancora a preferire l’utilizzo dell’automobile, nonostante il parco auto nazionale abbia un’età media di 12 anni, cosa che le rende ancora più inquinanti, per emissioni e per consumi.

Per raggiungere una decarbonizzazione dei trasporti, è necessario integrare soluzioni e tecnologie per la mobilità a basse o zero emissioni, accelerando le necessarie conversioni dei settori strategici. Accanto allo sviluppo delle ciclabili e delle infrastrutture per una mobilità attiva in ambito urbano, agli investimenti per un trasporto pubblico più efficiente e moderno, alle politiche di limitazione del mezzo privato nei centri urbani, l’elettrificazione dei mezzi di trasporto rappresenta l’opzione migliore e più impattante per liberare le nostre città da smog e intasamento veicolare, favorendo un sistema di mobilità più sostenibile e accessibile a tutti.
Parco auto circolante e infrastrutture
Siamo un popolo di conservatori, o forse siamo più poveri. In Italia il 30% delle auto non supera ancora lo standard emissivo Euro 3; l’87,7% del totale è ad alimentazione tradizionale (benzina e gasolio). Le auto ibride e quelle elettriche, pur in forte crescita, rappresentano ancora quote minime. Nel 2021 quasi un terzo delle immatricolazioni hanno fatto parte della filiera elettrica – ibrida, le prime proiezioni del 2022 le vede raggiungere una quota superiore al 40%, rendendo l’ibrido la motorizzazione più venduta in assoluto nel Paese.
Tra gli ostacoli a una maggiore diffusione, la lentezza nell’adeguamento delle infrastrutture per i veicoli elettrici, la capillarità della rete di colonnine di ricarica elettrica nazionale resta ancora bassa rispetto ai maggiori Paesi europei, benché sia il secondo Paese con auto circolanti elettriche, secondo solo ai Paesi Bassi. La concentrazione delle colonnine riguarda le principali città del centro-nord.
Il trasporto pubblico locale (TPL) svolge un ruolo importante nell’offerta di servizi di mobilità ai cittadini, ma è caratterizzato da un ritardo strutturale nell’aggiornamento del parco mezzi, che causa una scarsa qualità del servizio per i passeggeri, impatti ambientali significativi e costi di gestione più elevati per gli operatori.
L’Italia è nota anche per il suo ritardo nella dotazione di reti ferroviarie urbane rispetto alla media dei principali paesi europei, con meno del 40% di metropolitane, meno del 50% di reti tranviarie e il 50% di quelle ferroviarie suburbane. Una spinta evolutiva viene dai vari piani di investimento nazionali cofinanziati dalle risorse comunitarie (PNRR; PON Metro, PON Infrastrutture e Reti, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione).
Sharing mobility, una grande opportunità
La sharing mobility (o vehiclesharing: carsharing, scootersharing, bikesharing, monopattino-sharing) ha un peso notevole, nella mobilità urbana, per ridurre le emissioni, ed è sempre più diffusa: sono oggi almeno 190 i servizi offerti in 62 capoluoghi di provincia, capolista Milano e Roma (dati ultimo rapporto nazionale sulla Sharing Mobility), che sono tra le prime in Europa in termini di veicoli in sharing per abitante.
L’esplosione del segmento dei monopattini elettrici ha contribuito in gran parte a questo aumento, favorendo anche una maggiore diffusione territoriale dello sharing. I segmenti tradizionali, come il car sharing e in parte il bike sharing, soprattutto quelli cosiddetti free-floating, sono invece meno performanti e stanno in parte ridefinendo i propri modelli di business.

Grazie alla crescita dei monopattini le flotte dello sharing sono ormai composte per il 94,5% da veicoli a zero emissioni, contro lo 0,3% del parco circolante auto complessivo.
È evidente che questo modello di mobilità, figlio della digitalizzazione, rimane una grande chance per trasformare il modo di muoversi, specialmente in città, e risponde a diverse esigenze di sostenibilità, ambientale e sociale. Risponde anche a nuovi stili di vita e a una nuova cultura che vede le persone preferire la disponibilità di un servizio efficiente e flessibile di mobilità alla proprietà e gestione di un mezzo proprio (sempre più complessa e costosa).
Secondo McKinsey, la sharing mobility è uno dei driver nella trasformazione della mobilità, poiché i consumatori cercano opzioni di trasporto che siano comode, economiche e sostenibili. Si stima che possa generare ricavi fino a 1.000 miliardi di dollari entro il 2030.